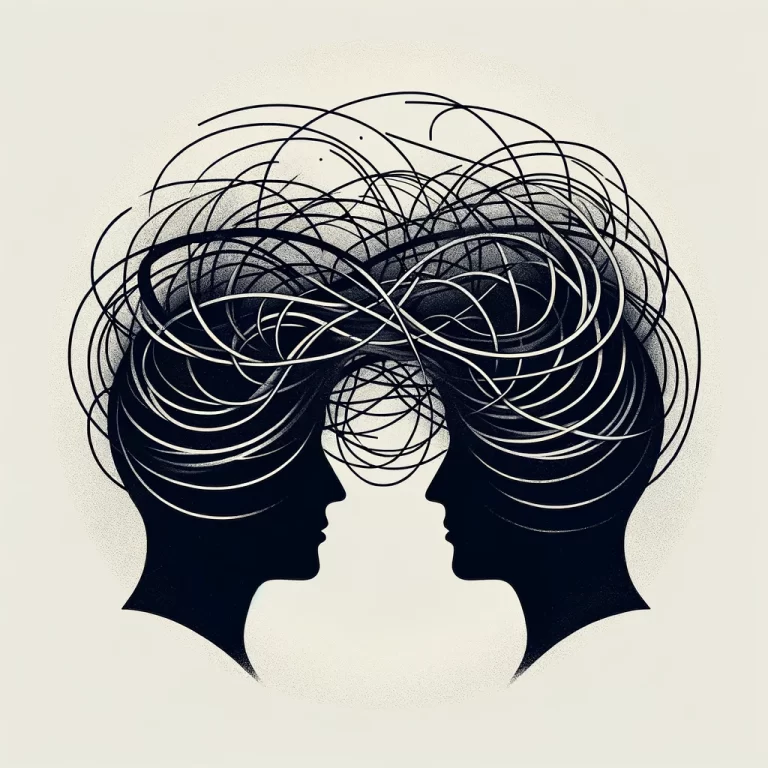Benedetto Coccia
Poveri Boomer 2: la vendetta
Abbiamo descritto i boomer come gli artefici della nascita della società contemporanea sorta dalle ceneri di quella “borghese” abbattuta dalla […]
Poveri boomer
Se pubblica sui social una immagine raffigurante un mazzo di fiori con la laconica didascalia “buona giornata” è un boomer, […]
Ho mal di testa…
L’importanza del contesto nella comunicazione… e non solo. “Ho mal di testa.” Una affermazione chiara e dal significato apparentemente univoco. […]
Le migrazioni qualificate nella storia
Le idee, le conoscenze e le competenze si sono sempre spostate da un Paese all’altro con le persone dando luogo […]
Le migrazioni qualificate nel ‘900
Possiamo dire che fino all’inizio del Secondo conflitto mondiale i flussi migratori furono caratterizzati, a parte rare eccezioni, dalle migrazioni […]
Le migrazioni qualificate fra ‘700 e ‘800
Fino al Diciannovesimo secolo le migrazioni di persone o gruppi altamente qualificati provenivano e si andavano ad inserire in realtà […]
Spunti di riflessione sulle migrazioni interne italiane dal dopo guerra agli anni ‘80
Al di là delle diverse articolazioni dell’esodo rurale, comunque, per coloro che decidevano di abbandonare il mondo delle campagne o […]
Per loro non c’era posto: il problema dell’alloggio. L’emigrazione meridionale al nord Italia.
Gli intensi movimenti migratori degli anni Cinquanta e Sessanta, che riversarono nelle città un imponente flusso di popolazione proveniente dalle […]
Lo spopolamento delle campagne italiane. Città vs campagna?
Dai dati ISTAT (ISTAT Sommario Statistiche storiche 1926 – 1985) risulta che nel 1961 oltre 20,2 milioni di italiani, pari […]
Le migrazioni dal sud al nord Italia. Il lavoro nelle cosiddette “cooperative”
Terminata l’onda lunga del boom economico, assistiamo alla netta contrazione nei flussi di mobilità interna che si verificò tra gli […]